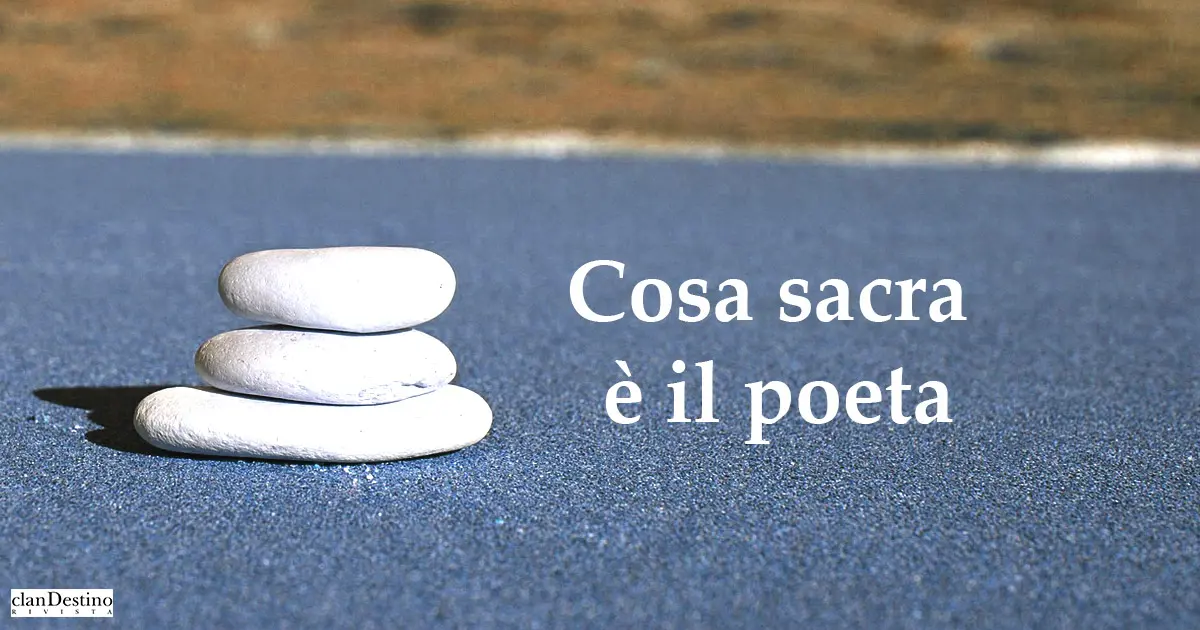Anteprima degli Atti del Convegno sul Sacro Poetico (Roma Università La Sapienza, ottobre 2025), che verranno pubblicati da Progetto Cultura
di Ilaria Giovinazzo
Sai, con l’argilla che tu hai scavato
Ho costruito un Buddha
È piovuto
Il Buddha è ritornato argilla
Insignificante come il cielo, sereno dopo la pioggia.
Ko-Un
Come sappiamo il termine ‘sacro’ deriva dalla radice indoeuropea ‘sak’, da cui il latino ‘sacer’, che designa una realtà che incute timore e allo stesso tempo attrae. Qualcosa che merita il nostro rispetto profondo, la nostra venerazione ma al contempo ci terrorizza, ci spaventa.
La sfera del sacro coincide quasi sempre con la sfera del divino: là dove il divino si manifesta, si rivela un dominio sacro. Le cose, che siano luoghi, oggetti, persone, animali, diventano sacre in quanto sono in relazione con l’assoluto, acquistano un valore sacro. Ma essi non sono sacri in sé stessi e di per sé: lo sono in quanto simbolo ed espressione del divino.
E dunque perché, come dice Platone nello Ione, il poeta è cosa sacra?
Il poeta è sacro perché, fin dall'antichità, è il portatore di un dono divino, il custode della memoria collettiva e del linguaggio. Il suo compito è quello di rivelare le verità più profonde, interpretare il mondo attraverso un linguaggio magico, diverso dal linguaggio quotidiano, e trasmettere emozioni che risvegliano l'immaginazione, fungendo da guida e figura profetica, anche se spesso isolata e incompresa dal resto della società.
Il poeta è il custode del linguaggio della comunità, dei suoi segreti, della memoria del suo popolo, è colui che riesce a vedere nell’abisso e ad accedere alla sfera numinosa del sacro, riportando a noi la sua visione.
E come il poeta riporta a noi questa visione? Lo fa attraverso la Parola.
La parola diventa lo strumento di rivelazione del divino, dell’imperscrutabile, dell’invisibile. In hindi il termine “parola” corrisponde al termine vāc. Vāc fu prima di tutta la creazione, prima che qualunque essere venisse in essere. Fu lei a iniziare il processo creativo.[1] Ogni parola contiene in sé la forza, la potenza creatrice. La Parola nei Veda è il mistero centrale che si colloca nel cuore della realtà, il principio vitale di ogni essere. La Parola è il linguaggio degli dei che gli uomini hanno appreso.
Il carattere sacro dava alla parola un valore di verità per cui falsità e menzogna erano considerate un tradimento alla comunità e al suo cammino storico.
La parola ha un valore sacro presso popoli distanti geograficamente, con mitologie, storie e visioni del mondo diversissime; alla parola si riconosce la potenza di creare dal nulla quanto esiste.
In un poema accadico è scritto: Quando in alto il cielo non era stato ancora nominato né la terra in basso…
Per molti popoli antichi il suono/parola precedeva qualsiasi creazione.
Per gli aborigeni australiani la creazione risale “al tempo del sogno” quando creature totem gigantesche attraversarono la terra cantando di ciò che incontravano in sogno, animali, piante, specchi d’acqua, rocce… con il loro canto tutti gli elementi furono creati.
Nel Corano: Creatore massimo dei cieli e della terra che quando ha decretato una cosa non fa che dire “sii” ed essa è (2,117).
In India i mantra sono il linguaggio magico per eccellenza. La sillaba sacra dell’Om è il seme, bindu, da cui ha avuto origine tutto l’universo. E il suono di quella sillaba è nel cuore di ogni essere vivente.
Nella mitologia dell’Antico Egitto i pensieri del creatore divennero gli dei e tutte le cose della terra, gli uomini e il mondo iniziarono a esistere in virtù della parola del dio che ne pronunciò i nomi ordinando che fossero.
Secondo i nativi americani il Grande Spirito dà ad ogni persona una medicina, un dono spirituale unico o un talento. La medicina può essere buona o cattiva a seconda di come la usiamo e dell’impatto che ha sulle persone. Una parola gentile può essere una buona medicina, una parola offensiva o scoraggiante è cattiva medicina. Le parole che gli sciamani usano per la guarigione sono conosciute come “benedizioni” e costituiscono vere e proprie azioni creative, come piantare un seme nel mondo. Spesso sono dei canti, delle poesie. La poesia può essere un potente strumento di guarigione.
Il canto poi si fa anche preghiera quando ci rivolgiamo direttamente al divino. La radice indoeuropea prach- rimanda all’atto del chiedere, domandare.
“L’idea che il poeta sia ispirato […] è qualcosa che effettivamente accompagna […] tutte le tradizioni perché vi è stata un’epoca nella quale la funzione della poesia era quella di comunicare con una zona oscura, esterna alla cerchia illuminata dal fuoco della tribù, dalla quale lo sciamano e il poeta […] dicevano che pervenivano i loro messaggi”. Franco Fortini (intervista RAI 8 maggio 1993).
Se pensiamo ai bambini piccoli che iniziano a dire le loro prime parole cercando di comunicare, di costruire la loro realtà attraverso il linguaggio, ci rendiamo conto di come questo linguaggio sia in qualche modo magico.
I bambini creano attraverso le parole l’universo delle loro esperienze fisiche e delle emozioni.
È una lingua che non parla solo della realtà ordinaria, ma proviene da un luogo ancestrale dentro di loro.
Col tempo impareranno a usare le regole della comunicazione adulta e le sue limitazioni e abbandoneranno quella lingua magica, potente e immaginifica.
Gli sciamani, in maniera simile ai bambini, utilizzano un linguaggio magico: parlano e comprendono il linguaggio degli animali e degli alberi e ritornano dall’incontro con gli spiriti con dei canti di potere. La pratica sciamanica include il salmodiare frasi, ripetute nella ritmica di formule magiche, simile a quella che si ritrova nelle cantilene infantili.
Anche i poeti, come gli sciamani e i bambini, custodiscono le qualità ancestrali e mistiche del linguaggio. La poesia istituisce un ponte tra i regni della realtà ordinaria e non ordinaria, permettendo a chi ascolta o legge di viaggiare oltre i confini della parola scritta, in una dimensione immaginale in cui ritrovare il Sacro come parte di Sé e del proprio quotidiano. La parola poetica in questo senso è maieutica.
“Poesia è un fare spirituale. Mi piace pensare che contemplare significhi guardare col tempio, dove tempio è l’esercizio di una certa cosa… La poesia è sacra scrittura”.
Franco Loi, da L'aria che passa - Conversazioni con Franco Loi, di Roberta Castoldi
Il poeta dunque è sacro perché nel momento in cui la parola poetica nasce dentro di lui per furore divino egli incarna la divinità e ricrea il mondo attraverso le sue parole. Posseduto dalla divinità, dall’ispirazione, accogliendola, egli si fa cosa sacra.
E questo ruolo, questo potere, questo dono, egli può utilizzarlo nel bene e nel male, per creare o per distruggere.
Il parlare spinge ad agire e può cambiare, in bene e in male, la storia e non solo la “grande” storia – gli esempi sono infiniti in tutti i tempi –, ma quella di ogni persona, di ogni gruppo, di ogni popolo.
Ricordiamo l’insistenza di don Milani perché tutti divengano “padroni della parola” intesa come espressione della dignità di ogni essere umano.
Attraverso la deformazione delle parole si giunge ad una “colonizzazione dell’intelligenza” (Julio Cortazar); questa pericolosa contraffazione, attraverso i mezzi tecnici di oggi (e non soltanto i social), tocca direttamente la vita privata, manipola il pensiero individuale, invade il subconscio senza che molti se ne rendano conto.
Fondamentale è, quindi, un linguaggio il più possibile vicino al vero, nel rispetto della realtà o, meglio, “l’onestà verso il reale” per riscattare la lingua della verità.[2]
Ed oggi è questo che i poeti contemporanei devono ricordare. Di fronte allo svilimento del linguaggio, di fronte all’annientamento di ogni principio morale ed etico, davanti alla distruzione della parola, al suo uso distorto e immorale e violento, alla sua strumentalizzazione e al suo abuso, il poeta rimane il custode del sacro volto del mondo e dell’Etica della Parola. È al poeta, a mio avviso, che spetta il compito di farsi portavoce dell’umanità e testimone dell’orrore, dello scempio, della follia dei tempi. È lui che può tornare ad essere guida e memoria. Occorre usare il linguaggio come arma di civiltà, rifondarlo per rifondare il mondo.
Non dobbiamo mai dimenticare che la letteratura può essere strumento di potere, incidere sulla società, educare gli uomini.
Chiudo con le parole di Lawrence Ferlinghetti:
“A che servono i poeti in un’epoca simile?
A che serve la poesia?
Lo stato del mondo reclama a gran voce che la poesia lo salvi.
[…] Poeta, sii la spia di Dio, se Dio esiste.
[…] Sii un occhio tra i ciechi.
[…] Parla. Agisci. Il silenzio è complicità.
Svegliati, il mondo va a fuoco!”
Leggi anche
- 2 settimane fa